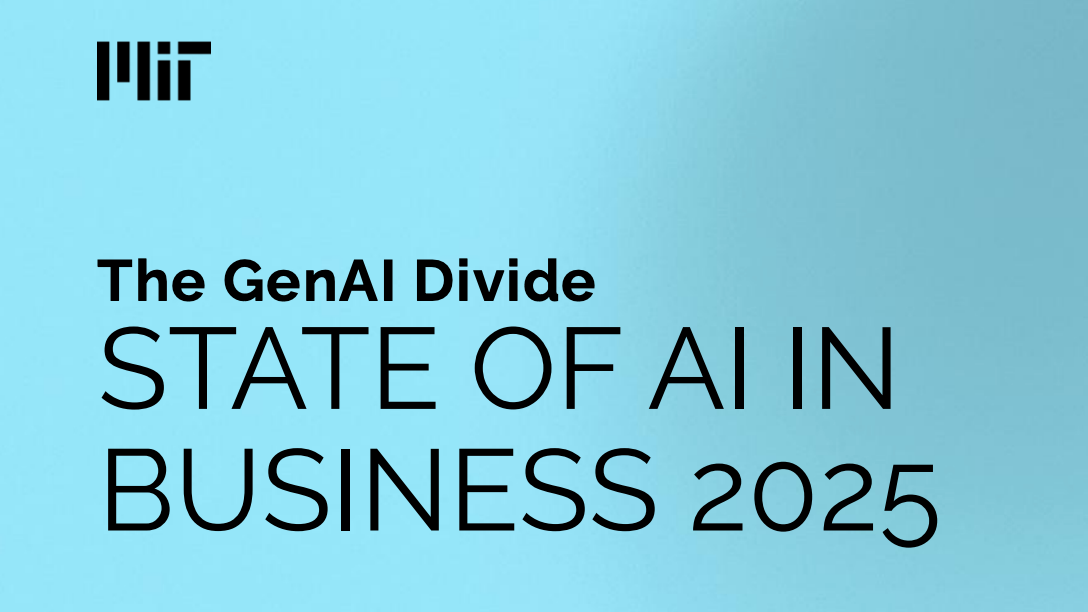Il rapporto The GenAI Divide – State of AI in Business 2025 propone un'analisi ampia e strutturata (oltre 300 casi reali, interviste e survey a leader aziendali), offrendo una fotografia dell'adozione dell'Intelligenza Artificiale Generativa. La base dei dati è in gran parte auto-riferita, quindi più indicativa di percezioni e tendenze che di numeri assoluti. Nonostante i limiti tipici delle ricerche qualitative, il documento delinea con precisione uno scenario interpretativo che merita attenzione.
Il concetto chiave: il GenAI Divide
Il cuore del rapporto è il GenAI Divide, il divario tra l'entusiasmo per l'adozione della Generative AI e i pochi benefici aziendali concreti finora misurati. In altre parole, la fotografia del 2025 è la proiezione del Gartner Hype Cycle sull'IA generativa: tanto clamore iniziale, poca ricaduta sul conto economico.
1. L'esplosione dell'hype
Le imprese hanno investito tra i 30 e i 40 miliardi di dollari (investimenti enterprise non totali del mercato) in soluzioni GenAI, soprattutto strumenti generici come ChatGPT e Copilot:
- oltre l'80% delle organizzazioni ha sperimentato o avviato piloti;
- il 40% ha già implementato i tool;
- ma il loro impatto resta marginale, limitato alla produttività individuale, senza incidere sui risultati economici.
Quando si tratta di soluzioni enterprise personalizzate, la situazione peggiora:
- il 60% le valuta,
- solo il 20% arriva al pilota,
- appena il 5% alla produzione.
Workflow fragili, mancanza di apprendimento contestuale e scarso allineamento operativo frenano il passaggio.
Risultato: entusiasmo alto, valore concreto scarso.
2. La fase di disillusione
Dopo l'hype iniziale, il rapporto individua una fase di stallo diffuso:
- il 95% delle organizzazioni non ottiene alcun ritorno economico;
- i piloti rimangono bloccati e solo il 5% arriva in produzione;
- nasce una vera e propria shadow AI economy: il 90% dei dipendenti usa strumenti personali come ChatGPT o Claude (contro il 40% di abbonamenti aziendali ufficiali), con ROI spesso superiore ai progetti corporate.
Anche settorialmente emerge una disruption nettamente polarizzata. Il rapporto misura questo fenomeno con il GenAI Disruption Index (scala 0-5): solo Tech raggiunge il massimo punteggio di 4, con nuovi competitor che guadagnano terreno e workflow che si trasformano. Media & Telecom si ferma a 2, mostrando contenuti AI-native e dinamiche pubblicitarie in evoluzione, ma con incumbent ancora dominanti. I restanti sette settori – sanità, retail, finanza, energia, manifatturiero – non superano 0.5, rimanendo sostanzialmente immutati nonostante diffusi piloti sperimentali.
È il classico "trough of disillusionment" del ciclo Gartner, con la cruciale differenza che la disruption si concentra in modo netto in pochissimi settori.
3. L'enlightenment selettivo
Chi supera il divide entra in una fase di illuminazione selettiva, trasformando l'IA in impatti misurabili sul conto economico. Ma come?
La barriera principale è il learning gap:
- la maggior parte dei sistemi non mantiene memoria, non si adatta al contesto, non evolve con i feedback;
- per task rapidi il 70% degli utenti preferisce l'AI, ma per compiti complessi il 90% si affida ancora agli umani – una divisione netta che rivela il limite strutturale degli strumenti attuali;
- gli strumenti consumer vincono in flessibilità e fiducia per lavori semplici, ma perdono drasticamente quando servono personalizzazione e memoria persistente per progetti articolati.
La preferenza gerarchica è chiara: AI domina per email e analisi di base (70%), umani dominano per tutto ciò che richiede continuità, apprendimento contestuale e adattamento nel tempo.
È qui che compaiono i primi Agentic AI: sistemi con memoria persistente, apprendimento iterativo e autonomia operativa, capaci di superare questa divisione netta tra semplice e complesso. Le prime implementazioni in customer service, finanza e sales pipeline dimostrano che solo colmando il learning gap si attraversa definitivamente il divide.
4. I playbook dei vincitori
Il rapporto traccia le pratiche comuni a chi riesce a creare valore con GenAI.
Dal lato dei builder (startup, vendor, consulenze):
- focus su use case ristretti ad alto valore;
- integrazione profonda nei workflow;
- scaling basato su apprendimento continuo, non su feature generiche;
- padronanza del dominio, più che UX appariscente (UX flashy);
- forte spinta alla customizzazione dei processi;
- adozione favorita da reti di fiducia (partner, system integrator, marketplace);
- utilizzo di framework che abilitano interoperabilità agentica, basi dell'Agentic Web.
Dal lato dei buyer (le imprese):
- trattano l'AI come BPO (Business Process Outsourcing), non come SaaS:
- approccio SaaS → compro un tool generico e lo provo;
- approccio BPO → chiedo al vendor di personalizzare l'AI per un obiettivo concreto di business (es. -20% costi legali, +40% velocità processi);
- scelgono il buy al posto del build: partnership esterne hanno un successo del 67% vs 33% delle soluzioni interne;
- decentralizzano le decisioni, dando ownership ai manager frontline e ai prosumer già esperti di AI;
- misurano i risultati su metriche reali di business (P&L, riduzione BPO, risparmi agenzie, retention clienti).
Il valore emerge in aree spesso ignorate:
- eliminazione di servizi BPO → 2–10M $ annui;
- riduzione delle agenzie esterne → -30%;
- customer retention → +10%.
Il rapporto chiama questo fenomeno Investment Bias: le aziende concentrano il 70% degli investimenti su marketing e vendite, trascurando funzioni di back-office (procurement, finanza) che offrono ROI ben più alti.
Verso l'Agentic Web
Superare il GenAI Divide significa fare tre scelte chiare:
- Acquistare, non costruire.
- Dare potere ai manager di linea, non solo ai lab centrali.
- Adottare sistemi integrati e capaci di apprendere nel tempo.
La destinazione finale è l'Agentic Web: un ecosistema di agenti intelligenti, interoperabili, capaci di negoziare, coordinarsi e condividere contesto tra vendor diversi.
Non più strumenti isolati, ma una rete di agenti che collaborano autonomamente grazie a protocolli comuni.
Come il Web 1.0 ha decentralizzato la pubblicazione e il commercio, così l'Agentic Web decentralizzerà l'azione: non più prompt manuali, ma coordinamento protocol-driven. Immaginiamo:
- un agente di procurement scopre un nuovo fornitore,
- un agente legale ne analizza il contratto,
- un agente finanziario ne calcola l'impatto economico.
Il tutto in automatico, in sincronia e senza intervento umano costante.
Secondo il rapporto, entro il 2026 chi avrà intrapreso questa strada avrà costruito un vantaggio competitivo duraturo. Gli altri resteranno bloccati sul lato sbagliato del Divide.
Conclusioni
Come anticipato all'inizio, questo rapporto va letto come una ricerca di natura qualitativa: le dimensioni del campione non consentono generalizzazioni che rappresentino in modo fedele l'intero panorama aziendale. La maggior parte delle evidenze – tassi di adozione, barriere riscontrate, metriche di successo – proviene infatti da interviste e sondaggi auto-riferiti, basati su dichiarazioni di executive e manager, più che da dati oggettivi e verificabili (si veda, ad esempio, alle pp. 6–7 e 11). Ne derivano inevitabilmente potenziali distorsioni, quali bias di richiamo, desiderabilità sociale o sovrastima dei risultati. Anche exhibit come l'"AI Market Disruption Index" (p. 4) o le valutazioni delle barriere (p. 11) si fondano su valutazioni derivate da interviste e frequenze riportate, che lo stesso rapporto definisce direzionali al meglio (p. 10). Senza una triangolazione con metriche indipendenti – audit finanziari o dati longitudinali – questi risultati rischiano dunque di restare parziali e soggettivi, riducendone l'affidabilità per decisioni realmente evidence-based. Un esempio: i "Cinque Miti sul GenAI nelle Imprese" (p. 7) smontano luoghi comuni diffusi, ma lo fanno con un sostegno empirico limitato, tralasciando aspetti rilevanti come gli ostacoli regolatori, non confutati da adeguate contro-evidenze.
Il nodo più delicato è che il rapporto, pur fornendo spunti preziosi, si concentra nella promozione di concetti e framework specifici – dall'Agentic Web a NANDA, MCP e A2A (pp. 18, 22–23) – che riflettono in parte l'advocacy degli autori verso determinati paradigmi tecnologici. Da un lato, quindi, il documento ha il merito di portare alla luce comportamenti e tendenze che contribuiscono a spiegare il GenAI Divide, dando visibilità a dinamiche spesso percepite ma raramente analizzate con questa chiarezza e autorevolezza. Dall'altro, legando a doppia mandata il superamento del divide a una questione di scelta di paradigma tecnologico, rischia di semplificare troppo: non basta individuare l'approdo – l'Agentic Web – se mancano le istruzioni di navigazione e, soprattutto, l'attitudine motivazionale necessaria ad affrontare il viaggio che porta oltre il divide.
Saranno questi gli elementi centrali – le "mappe" (le metodologie concrete) e le "bussole" (i principi guida e motivazionali) per affrontare il percorso – a cui dedicherò un approfondimento mirato in un prossimo post.